 C’è un equivoco che cammina tra i banchi delle nostre scuole. L’idea che educare alla libertà significhi insegnare la disubbidienza. Non sono pochi a crederlo. Ma non è così. Si tratta di un errore che molti perpetuano rimanendo attaccati a brandelli di vecchie superstizioni. Uno sbaglio che spesso si commette per disattenzione, talvolta per pigrizia, quasi sempre per paura. Che la scuola educhi alla libertà è allora tante volte un miraggio.
C’è un equivoco che cammina tra i banchi delle nostre scuole. L’idea che educare alla libertà significhi insegnare la disubbidienza. Non sono pochi a crederlo. Ma non è così. Si tratta di un errore che molti perpetuano rimanendo attaccati a brandelli di vecchie superstizioni. Uno sbaglio che spesso si commette per disattenzione, talvolta per pigrizia, quasi sempre per paura. Che la scuola educhi alla libertà è allora tante volte un miraggio.
L’equivoco induce a credere che educare alla libertà conduca all’apologia di comportamenti contestatori, all’esercizio di atteggiamenti oppositivi e alla confusione in classe. Succede perché il concetto di libertà, quando viene declinato nel contesto della vita scolastica, è facilmente frainteso con la mancanza di ordine, la perdita di ogni equilibrio, l’eccesso di autarchia e l’esaltazione del personalismo.
In una scuola elementare educare alla libertà significa invece condurre i bambini per mano in un faticoso cammino di autonomia, consapevolezza di sé, senso di responsabilità e comprensione di cosa significhi davvero camminare insieme.
È vero, i bambini delle mie classi non fanno file, non hanno libri di testo, decidono loro come scrivere sul quaderno, arrivano a fare ricreazione da soli in cortile, sono incoraggiati ad avere opinioni diverse da quelle del maestro, in certi momenti possono stare scalzi o ballare sopra i banchi, ma questo non farà di loro dei sovversivi. Sfido chiunque a vedere in loro dei bambini disobbedienti, ribelli o anche solo un po’ indisciplinati. Tutto il contrario. La libertà concessa gradualmente e conquistata pezzo per pezzo è qualcosa che poi bisogna difendere e continuare a meritare. Questo i bambini lo sanno bene. E i bambini, ora che sono arrivati in quarta, legittimano la libertà acquisita con il senso di responsabilità e la dimostrazione di essere capaci a condividere un percorso comune. Anche tra i contrasti che possono nascere, anzi, soprattutto in mezzo alle situazioni problematiche. La libertà non è star sopra uno albero, scriveva Gaber, la libertà è partecipazione.
La libertà non è un traguardo, ma un sistema di orientamento. Non è la meta di un viaggio, ma sono le scarpe che ogni giorno ci fanno camminare. E a chi crede che educare alla libertà significhi spingere verso la trasgressione direi che è vero proprio il contrario. È orientando alla soggezione e alla sottomissione che si insegna la disubbidienza.
p.s.
Il meraviglioso murale in copertina è opera dell’artista polacca Natalia Rak































































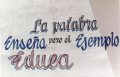

Maestro Flavio hai presente i commenti che i più fanno al metodo montessori? Tu hai risposto egregiamente. E’ molto bello questo discorso sulla libertà, apre molti scenari, così come quando si vuole quantificare l’intelligenza. Mi sa che è maturo un caffè….
Un caffè ci sta sempre bene, nonnalaura, fossimo anche sul cassero di un veliero nel pieno di un uragano.
Antonio Gramsci nelle sue bellissime lettere dal carcere ai figli, ancora bambini, spesso ricorda loro quel che tu dici: per essere liberi bisogna esercitare su se stessi una certa severità, essere coscienti che la nostra libertà non può essere tale se è a scapito di quella altrui. Gli altri sono un vincolo e una risorsa, entrambi gli aspetti hanno modalità e forme che possono essere discusse, ma non negate.
Trovo i tuoi “elzeviri” commoventi , soprattutto in questo periodo buio per la nostra scuola.
Grazie big chief. Anni fa, a proposito della libertà, scrissi questa cosa ai bambini che avevo in classe. Le lettere di Gramsci dal carcere non le ho lette, ma, da quanto dici, credo che in qualche modo il pensiero coincida.
Cari bambini,
la libertà è il bene più grande di tutti i beni preziosi.
Di gran lunga il più grande.
Ma è come un cavallo selvaggio.
Se non impariamo a domarlo non ci condurrà mai dove vogliamo
e deciderà lui dove portarci, anche in mezzo alle spine.
Vorrei che ci pensaste.
Libertà significa anche
fare il nostro dovere
senza nessuno che ci costringe a farlo.
È obbedire a noi stessi
Francisco Varela, biologo cileno, parlò ad una conferenza di “know how” per l’etica, quella capacità di reagire alle ingiustizie, ai comportamenti dannosi (nostri e altrui) per la collettività, al bisogno di soccorso, mediante azioni spontanee, apprese durante l’infanzia da adulti consapevoli e responsabili. Il tuo aforisma poetico gli sarebbe piaciuto.