 Le parole sono importanti. La scelta di un vocabolo al posto di un altro spesso risponde al bisogno di sottolineare un orientamento, manifestare un intento, sottintendere un insieme di valori. Può indicare perfino una buona dose di imbarazzo o l’ipocrisia di un intero sistema (basta pensare al diversamente abile o all’operatore ecologico). Così espressioni che consideriamo equivalenti succede che non lo siano affatto. Una parola racconta più di quello che semplicemente descrive.
Le parole sono importanti. La scelta di un vocabolo al posto di un altro spesso risponde al bisogno di sottolineare un orientamento, manifestare un intento, sottintendere un insieme di valori. Può indicare perfino una buona dose di imbarazzo o l’ipocrisia di un intero sistema (basta pensare al diversamente abile o all’operatore ecologico). Così espressioni che consideriamo equivalenti succede che non lo siano affatto. Una parola racconta più di quello che semplicemente descrive.
Questo la scuola dovrebbe insegnarlo.
Allo stesso tempo una lingua impoverita è triste come un registro delle assenze pieno di nomi. Perché semplificare il lessico e ridurlo a un numero esiguo di termini significa limitare la possibilità di espressione e quindi di pensiero. È cercare di dipingere un tramonto con un colore soltanto.
Anche questo la scuola dovrebbe insegnarlo.
Quello che succede è che i nostri istituti scolastici, invece di essere luoghi di resistenza e rappresentare roccaforti dove starsene al riparo e organizzare una controffensiva all’andamento generale di indebolimento della nostra lingua, sovente vi si adeguano (è sufficiente prendere in esame i programmi e i libri di testo per rendersene conto).
Le stesse parole che la scuola italiana utilizza per descrivere se stessa e il lavoro che si svolge al suo interno sono il segnale di una resa. Perché, quando un contesto culturale attinge a piene mani da un settore molto tecnico, come quello economico, si sottomette inesorabilmente alla logica dell’impoverimento formativo. Anche nella scuola si parla ormai di debiti, crediti, dirigenze, acquisizioni, prodotti, competenze, plusvalenze, obiettivi, valutazioni.
Questa invasione di termini, mutuati da un ambito caratterizzato dalle logiche asettiche del profitto, del consumo, della competizione inesorabile in un mercato globalizzato, è più significativa di quanto sembri. È il segnale evidente che la scuola ha subito una trasformazione pericolosa, non resistendo alle lusinghe di apparire al passo coi tempi. La conduzione aziendalistica non lascia spazio ad altro che non realizzi un utile immediatamente calcolabile e spendibile. E non è un caso se alcune discipline, lontane da quell’idea di utile immediato, rischiano di estinguersi sullo slancio di una finta esigenza di modernità (vedi alla voce: Liceo Classico).
Il linguaggio dentro la scuola assume proprietà da consiglio d’amministrazione. E la scuola si trasforma. Da giardino delle conoscenze, dove passeggiare senza preoccuparsi troppo dello scorrere del tempo, si fa sala d’attesa, dove restare seduti il meno possibile prima di finire stritolati tra gli ingranaggi di un sistema economico che indurrà a correre senza più fermarsi.
p.s.
La vignetta in copertina è naturalmente di Altan

















































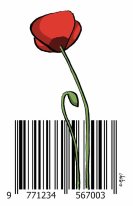













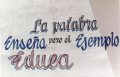

Lingua Materna: la lingua ostensiva, metonimica, spesso stupendamente dialettale, ad alto grado di creatività (lessico famigliare a condivisione inizialmente ristretta: Mamma-Bambina/o). Di tutto questo il movimento delle donne si è occupato per anni. Esistono testi – fra riflessione filosofica e insegnamento della Lingua come compito femminile, o da maschi “riconoscenti” – che ne hanno documentato il percorso. Oggi, nel feroce processo di aziendalizzazione che descrivi si è inaridita la stessa radice della Lingua Materna, nel colpevole, ignorante oblio proprio di Professoresse, Ministre, Sottosegretarie…femminile plurale.
già. Big chief, qui certo la questione si allarga, finendo per delineare macabri scenari…
Perfetto
grazie Demart81 e benvenuto a bordo